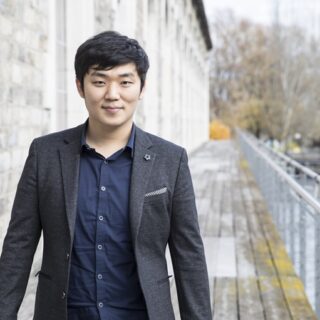DONIZETTI Anna Bolena S. Alberghini, C. Remigio, A. Vendittelli, L. De Donato, R. Gatin, P. Gardina, M. Nardis; Coro Claudio Merulo di Reggio Emilia, orchestra I Classicisti, direttore Diego Fasolis regìa Carmelo Rifici scene Guido Burganza costumi Margherita Baldoni, luci Alessandro Verazzi
Reggio Emilia, Teatro Municipale “Romolo Valli”, 9 febbraio 2024
Anna Bolena è opera difficile, tra le più complicate di Donizetti, che con essa colse il primo successo determinante della sua carriera, sperimentando nella composizione giudiziose vie nuove in alternanza a passi di più tradizionale taglio, immediatamente apprezzabile dal pubblico di allora. Un’opera a mezzo del guado, come viene spesso definita dai critici, intendendo sottolineare lo sforzo d’affrancatura del musicista bergamasco dagli stilemi rossiniani senza avere ancora individuato la sua cifra peculiare (come la ritroveremo dalla Lucia di Lammermoor). È un’opera drammaticamente statica, costruita, si potrebbe dire, più da pannelli a sé stanti (un poco al modo col quale Ciaikovski avrebbe anni dopo trattato l’Onegin da Pushkin) che su scene consequenziali.
Da questo punto di vista, l’idea di una scena costituita da una piattaforma girevole sopra la quale era issato un muro di grigia calce rotante in modo da suggerire (così scrive il regista Rifici) diverse prospettive da cui osservare gli spazî, che – secondo il regista — son antri dell’anima e non ambienti realistici, poteva essere una soluzione interessante. La realizzazione scarsamente efficace (le diverse prospettive non si coglievano), però, dava l’idea di un mero espediente traverso il quale si cambiava l’apparenza perché nulla cambiasse nella sostanza, che rimaneva immota ed inespressiva.
Fulcro della regìa di Rifici era l’imbianchino. Uno strano personaggio in tuta bianca che entra in scena ai primi accordi dell’ouverture (ormai si sa che non la si può più ascoltare a sipario calato e – costi quel che costi – qualcosa da mostrare si deve inventare), spingendo una lunga scala a ruote. Accosta la scala al muro, ci si inerpica sopra e spatolando con un cencio schizza quel che a me parve il muso d’un can bastonato. All’inizio del secondo quadro del prim’atto la scena si ripete e – spatolando, spatolando – l’imbianchino completa il muso trasformandolo in un volto femminile (quello di Bolena, a confrontarlo col ritratto famoso dello Holbein juniore), giustamente volto a mestizia: al second’atto su una guancia comparirà una lacrimuccia discreta. Stavolta l’azione, però, è giustificata. La scala servirà infatti a Smeton – che aveva iniziato a cantare la sua romanza appollaiato su d’una finestra e penzoloni sul vuoto – a scendere senza rompersi il collo per chiudere in bellezza e ricevere l’applauso del generoso pubblico.
Ebbe ragione Nicola Cattò, il quale – recensendo le recite luganesi di questa Bolena – scrisse che la regìa di Rifici poneva fine alla diatriba sfiancata tra “regie tradizionali” (ma di quale tradizione si parla?) e “regie moderne” (termine pericolosissimo, moderno, dai significati sfaccettati come un prisma!): il punto, infatti, è piuttosto distinguere tra regìe che hanno idee e regìe – come questa o come quelle nihilette – costruite su grami escamotages per nascondere il vuoto di sostanza: ma è come cacciare la polvere sotto il tappeto.
Il direttore Fasolis ha il merito non piccolo di far suonare l’orchestra a un diapason più umano, in uso nell’Ottocento e ancora, verso la fine di quel secolo, suggerito da Verdi come il diapason ideale, col la a 430 Hz (l’esperimento andrà ripetuto, allargato e non escluderei fosse il grimaldello per dare nuova vita all’opera lirica: il lettore può trovare su YouTube un video di Piero Cappuccilli che, ospite allo Schiller Institut, accenna un par di passi verdiani famosi a 432 e poi col diapason moderno, mostrando come nel primo caso la voce galleggi più elasticamente colorandosi di un più vario ventaglio di tinte). Oltre però non riesce ad andare, e pare non saper bene dove mettere le mani (Donizetti non è Benedetto Marcello), navigando a vista in una partitura alla quale non riuscì ad imprimere alla musica il necessario élan, la flessibilità di tempi che perdurano rigidi e – nella maggior parte dei casi – privi di nerbo, poco sostenendo i cantanti che in più d’una occasione parvero abbandonati a sé stessi. Mancò una vera e propria concertazione, l’intervento direttoriale limitandosi all’accompagnamento delle voci. La Bolena – è vero – è opera “da cantanti”, ma questi vanno supportati, specialmente quando, come in questo caso, tra loro non vi sono personalità ‘forti’.
Anna Bolena è un personaggio complicato, modello non soltanto abbozzato d’Elisabetta di Valois della quale pare anticipare anche la drammatica vicenda personale: sposa obtorto collo ma che si vuole fedele (la regìa di Rifici, abbarbicandola al collo dell’amato Percy ogni volta che può, qualche dubbio, a dir vero, lo mette) a un re dispotico, reo lui stesso dell’errore di cui accusa la moglie (ed Eboli replica Seymour anche nel contrasto tra ambizione e senso di colpa, sebbene nel personaggio donizettiano, a differenza che in Verdi dove il pentimento è finale, i due stati convivano da sùbito), fedele benché innamorata d’un altro uomo, amore ch’era lecito perché precedente le nozze regali. In Anna la questione, come si sa, è complicata dal fatto che le nozze non furono stabilite a tavolino da altri, come nel caso d’Elisabetta, ma da lei stessa – per ambizione – cercate: il personaggio ha dunque un lato oscuro che l’immacolata eroina verdiana non conosce. Per questo servono una Callas, demònica, la grinta d’una Gencer, la forza di seduzione drammatica d’una Suliotis, l’iperbolicità astratta e barocca della Sills, il patetismo scolpito d’una Theodossiou (già cantatrici sublimi come la Caballé o la Devia, superbe nel Devereux e nella Stuarda, mi sono sempre apparse delle Bolene un poco troppo paciose). Carmela Remigio ha voce piccolina e personalità modesta, votata a ruoli perlopiù patetici, drammaticamente semplici (i personaggi in cui l’ho ascoltata maggiormente distinguersi son quelli di Desdemona e di Giulietta, nei quali sapeva far del canto una delizia), ma qui resta imbrigliata nelle debolezze retoriche del libretto di Romani, che disegna una regina troppo indulgente a piangersi addosso, la statura regale della quale andrebbe – perciò – ritrovata dall’interprete col ricorso a risorse personali, che fecero difetto. L’Anna della Remigio è debole, disorientata, quasi incoronata Zerlina “vorrei-e-non-vorrei”; e i suoi rari scatti d’orgoglio parevano piuttosto plebee crisi isteriche. Ovvio che dal punto di vista del mero canto alla Remigio non si possa appuntare nulla e momenti apprezzabili non mancarono, soprattutto nel duetto con Giovanna e al finale, con lo splendido legato di “Al dolce guidami castel natìo” in riuscito contrasto con lo sbalzo frammentato della cabaletta.
Ma se il trionfatore della serata risulta Percy — un ruolo molto sciocco che Donizetti (forte dell’arte di Rubini) rese una gran parte tenorile – significa che qualcosa non è tornato. Anche perché il tenore Gatin canta bene, fraseggia con gusto vario e bell’accento, lancia acuti squillanti, si disimpegna piuttosto bene nelle agilità e s’avventura perfino in qualche, migliorabile ma ammirevole, filatura (l’artista deve aver tenuto presente gli appunti mossigli da Nicola Cattò per la prova svizzera di un’eccessiva ‘voce piena’), ma ci ha un timbro da comprimario, a tratti quasi comico: sùbito la memoria è corsa al ‘mitico’ Nicola Tagger d’una antica Zelmira napoletana — cantava bene, ma aveva un vocino da zanzara che faceva sorridere –, della quale (a parte la registrazione fortunosa ma ascoltabile) ho avuto testimonianza diretta d’un che v’assistette. Altra cosa fu il tenore romantico “inventato” da Rubini!
Molto brava Arianna Vendittelli, sia vocalmente che scenicamente: riuscitissimo lo spogliarello al prim’atto, che la cantante, con la recitazione e il canto, rende molto più conturbante di quanto l’atto registico in sé non suggerisse (un top sfilato che lascia le spalle nude su una canotta nera) – è quell’azione che sovreccita Enrico facendolo risolvere definitivamente a liberarsi d’Anna. Ma Giovanna rimane un personaggio sussidiario.
Simone Alberghini alle prese col personaggio drammaturgicamente più ‘nuovo’ dell’opera, il “tremendo ottavo Enrico”, è un esempio di filologia applicata: il ruolo di Enrico fu scritto, infatti, per Filippo Galli, grande basso rossiniano che nel 1830, dicono le cronache, manteneva intatta la sua imponenza drammatica ma era vocalmente ridotto al lumicino. Così Alberghini, che la voce timbricamente bella non l’ha mai avuta ed ora appare di molto affiochita, si conferma attore formidabile e fraseggiatore intelligente. Ma Ghiaurov, ma Plishka, ma Ridderbusch (a Colonia, 1967), ma Christoff (a Roma nel ’76), ma Nesterenko, ma Ramey, ma Pertusi… Altre voci, altri Regi, altre emozioni.
Nulla di tragico, ma il problema è proprio quello.
Bernardo Pieri